Guarda avanti e ignora il licantropo.
Lo ripetei a me stessa mentre acceleravo il passo. Non era stato difficile identificare l’ombra, accovacciata su un bidone della spazzatura a rovistare in mezzo al suo contenuto. Anche se non avesse indossato al polso la fascia giallo brillante richiesta dalla legge per qualificarsi come ombra, in quella e nelle altre creature c’era qualcosa che le rendeva facilmente riconoscibili.
Portavano in loro una minaccia di pericolo che provocava una profonda ritrosia in noi normali esseri umani, quando un’ombra si trovava sul nostro cammino. Avevano movenze ferine e occhi vuoti, come se tutto ciò che in loro era una volta umano e reale fosse stato prosciugato quando erano stati infettati dalla sorgente.
Ciò significava che quell’ombra, nonostante sembrasse giovane per essere già stata trasformata – non poteva avere più di undici anni – avrebbe potuto farmi a pezzi se avesse perso il controllo.
Tuttavia il fatto che fosse fuori in strada, per di più con la fascia di identificazione, dimostrava che doveva essere un esemplare più debole e in terapia con i farmaci adeguati a curare la sua sofferenza. Altrimenti sarebbe stata opportunamente protetta all’interno di una academy.
“Non fissarla, Hera,” disse la mia amica Moa.
“Come può essere in giro per le strade?” chiesi, abbassando la voce mentre passavamo accanto all’ombra. “Pensavo che avessimo delle squadre per tenerle nascoste alla vista.”
Moa mi rivolse un’occhiata tagliente, che mi ricordò quanto diverse fossero le nostre vite.
Lei non era al corrente della verità, del pericolo rappresentato dalle ombre. Poteva vivere nell’ignoranza, fingere che il mondo fosse un posto sicuro, mentre io vedevo bene come la gente venisse massacrata da ombre fuori controllo. D’altra parte la sua famiglia gestiva un piccolo negozio dell’usato in conto vendita, mentre mia madre era senatrice a capo della commissione per il controllo delle ombre e mio padre dirigeva una delle aziende farmaceutiche più grandi del Paese.
Io ero Hera Weston, figlia unica di Zachary e Regina Weston, il che significava che non potevo permettermi il lusso di non sapere.
In ogni caso la assecondai, fingendo di non avere idea del motivo del suo biasimo nei miei confronti, perché non c’era motivo di litigare ancora su quell’argomento. Un sorso disinvolto dalla mia bottiglia d’acqua contribuì alla finzione. “Che c’è?”
“Sta solo cercando di procurarsi qualcosa da mangiare. Hai idea di quante ombre vengano cacciate di casa quando si trasformano? Di quante a quel punto non possano trovare un lavoro?”
“Non si trasformano. Vengono infettate e muoiono,” ribattei io, ma continuai a camminare per evitare che mi fornisse un’altra interminabile spiegazione politicamente corretta sul fatto che non ‘morissero’ realmente.
Moa era una di quelli che pensavano che le ombre fossero solo alterate, che fossero ancora le persone che erano state da esseri umani. Non era così, ovviamente, e se avesse ascoltato le lezioni a scuola o prestato attenzione ai notiziari, lo avrebbe saputo.
La sorgente, una sostanza che filtrava attraverso invisibili lacerazioni tra il nostro mondo e l’oscurità, poteva infettare alcuni umani. Quando accadeva, l’infezione provocava mutazioni così drammatiche che solo un pazzo avrebbe considerato l’ombra risultante come la stessa persona di prima. Le infezioni sembravano casuali, poiché le lacerazioni non potevano essere né trovate, né riparate.
Facevano semplicemente parte della vita.
“Tra l’altro,” aggiunsi, cercando di offrire le parole successive come ramoscello d’ulivo mentre passavamo accanto ai negozi che costeggiavano il centro commerciale all’aperto, “è per questo che abbiamo dato vita alle academy, per prenderci cura di loro in sicurezza e individuare le terapie migliori.”
“Quelle academy sono prigioni,” sbottò Moa, tirandomi per un braccio per fermarmi e tracciare tra noi la stessa immaginaria linea di demarcazione lungo la quale ci eravamo scontrate per anni. Mi affrontò come se fossimo impegnate su un campo di battaglia invece che davanti a una boutique di alta moda. “I bambini vengono sottratti ai genitori e gettati lì dentro. Spesso vengono sottoposti a esperimenti, drogati e chissà che altro.”
“Devi smettere di leggere i giornali scandalistici. Sei mai stata in una di quelle academy?”
“No”, ammise con tranquillità. “E tu?”
“Sì. Due anni fa, sono stata con mia madre alla Jasmine Academy. Posso assicurarti che lì non accadeva nulla di ciò di cui parli. Le ombre erano serene, in salute e incapaci di fare del male a se stesse e agli altri. Non è questo l’obiettivo?”
Moa scosse la testa. “Sei ingenua, Hera. Pensi che posti come quello vogliano far sapere alla gente cosa succede davvero? Pensi che semplicemente mostrino tutte le atrocità che commettono ai pezzi grossi che vengono in visita? È tutta una trovata pubblicitaria per far sì che la gente autorizzi il governo a sovvenzionarli con tutti i soldi che vogliono. Si tratta solo di mantenere la paura in modo da non farci prestare attenzione alle violenze che vengono perpetrate all’interno.”
Sospirai e lasciai cadere la conversazione. Avrei potuto discutere con lei tutto il giorno, cosa che era già successa in passato, ma Moa non aveva idea di cosa fosse il mondo reale. Non ero arrabbiata con lei per questo; anzi, a volte la invidiavo.
Sarebbe stato bello addormentarsi ogni sera senza sapere cosa fosse in agguato nell’ombra. Ricordavo ancora la prima volta in cui avevo visto un licantropo completamente trasformato, l’orrore che avevo provato mentre cercava di forzare le catene d’argento che lo avvolgevano, mentre ruggiva. Mia madre mi aveva portato con sé perché era preoccupata della mia infatuazione per le ombre, cosa comune a tante adolescenti.
La forza, la ribellione, il pericolo rappresentato da qualcosa di così potente erano inebrianti e la maggior parte delle persone attraversava una fase in cui pensava di poterle cambiare. Perché noi donne sentissimo il bisogno di provarci, di lavorare su personalità ormai deviate, non lo capivo più.
Non dopo aver sperimentato la profondità del terrore di trovarsi faccia a faccia con un’ombra che avrebbe potuto squarciarmi la gola con gli artigli in un batter d’occhio. Quel giorno mi ero resa conto che il mondo era molto più pericoloso di quanto la maggior parte della gente sapesse.
Moa subiva ancora quella fascinazione perché i suoi genitori erano persone dal cuore tenero che non le avevano insegnato a essere più cauta. Alla fine avrebbe imparato. Lo facevano tutti, perché il mondo non permetteva alle persone di mantenere a lungo le proprie illusioni.
Così, invece di continuare a perorare la mia causa, indicai una bancarella poco più avanti. “Andiamo laggiù a vedere le collane.”
Moa sospirò pesantemente, come se stesse cercando di mettere un freno alla sua rabbia e come se fossi io ad avere un carattere difficile, poi annuì. “Certo. Magari ne troviamo di abbinate.”
Non c’era molta scelta, ma si trattava di un perfetto diversivo. Mancavano solo poche settimane all’inizio del nuovo anno accademico e non avremmo frequentato le stesse facoltà.
Moa era stata ammessa all’università pubblica locale, che le avrebbe permesso di laurearsi in economia per poter sostenere e infine rilevare il negozio di famiglia.
Io, invece, avevo sulla scrivania la lettera di accettazione in una delle migliori università del Paese. Avevo buoni voti, ma il fatto che nell’edificio vi fosse una cosiddetta ‘ala Weston’ e che il mio cognome fosse Weston mi garantiva l’ingresso. In effetti non avevo nemmeno presentato la domanda di ammissione. Una telefonata da parte di mio padre, e le porte si erano spalancate.
Moa aveva tenuto la lettera tra le mani fissandola come se fosse stata il Santo Graal. E io? L’avevo abbandonata sulla scrivania e che si fottesse. Attraversare il Paese per frequentare l’università mi sembrava terribile. Un altro chiodo nella bara del mio futuro, il futuro che i miei genitori avevano preparato per me prima ancora che nascessi.
L’istruzione giusta, la carriera giusta, il marito giusto. Era un percorso predefinito verso la perfetta vita da piccola Weston che volevano conducessi. E io arrancavo su quel percorso perché... quale altra scelta avevo? Anche in quel momento, a diciannove anni, ero incastrata. L’età di un’adulta e la libertà di una bambina.
Un braccio mi circondò la vita, facendomi girare prima che delle labbra si posassero sulle mie. Aaron inghiottì il mio sussulto di sorpresa e si mise a ridere quando gli diedi uno schiaffo sul petto.
“Non avvicinarti a me di soppiatto,” sbottai.
Lui mi rivolse un sorriso sghembo. “Allora non stare lì impalata con l’aria di chi vuole un bacio. Non si sa mai chi potrebbe accogliere la tua offerta.”
Scossi la testa, sorridendo della sua sfrontatezza.
Il marito giusto. Quel pensiero mi spense il sorriso.
Era lui, Aaron. Il figlio di un socio in affari di mio padre: i nostri genitori avevano di fatto pianificato il matrimonio quando ancora sgambettavamo al parco giochi con il pannolino addosso. Io ero cresciuta sapendo cosa ci si aspettava da me e mi ero allineata prima di essere abbastanza grande da mettere in discussione il futuro che mi avevano organizzato.
In ogni caso Aaron non era poi così male. Era affascinante, bello, ricco. Il sesso era tollerabile e non mi trattava mai male. Non avevo provato le farfalle nello stomaco e non mi ero riempita la testa di sciocchezze perdendola tra le nuvole, ma ero piuttosto sicura che tutte quelle cose appartenessero solo a libri e film sdolcinati.
Nel mondo reale, ‘non male’ era il massimo a cui una persona potesse aspirare.
“Cosa state guardando?” chiese lui, attirandomi contro di sé.
“Collane,” spiegai. “Io e Moa volevamo prenderle abbinate.”
“E io?”
“E tu cosa?” chiese Moa con un sorriso. Aaron le era sempre piaciuto, probabilmente più di quanto piacesse a me, ma era stata rispettosa della nostra relazione a prescindere.
“Beh, voglio dire, abbiamo sempre fatto tutto insieme fino ad ora. Dovrei fare parte anch’io della faccenda delle collane.”
Alzai gli occhi al cielo. Aaron sapeva essere terribilmente appiccicoso a volte, ma non aveva torto. Era stato amico mio e di Moa, un po’ come in uno strano triangolo amoroso, per la maggior parte delle nostre vite.
“Non indosserò due collane.”
Moa allungò una mano, staccò da un gancio un cartoncino bianco da cui pendeva un ciondolo d’argento, e me lo porse. “Perché non prendiamo delle catenine? Così possiamo scegliere il ciondolo che vogliamo che ognuno di noi abbia, e avremo sempre i ciondoli abbinati ovunque andremo.”
“Questa è un’idea tremendamente sentimentale, e io l’adoro.” Aaron prelevò un ciondolo dall’espositore. “Guardate, un orso: è perfetto per me perché sono grosso e tosto e super virile.”
Moa fece un sorrisetto e prese un ciondolo a forma di topo. “Oppure questo, perché ti ficchi costantemente del formaggio in bocca e sei piuttosto fastidioso.”
Aaron si portò una mano al petto come se fosse stato ferito dalle sue parole. “Bene, da me non avrai nessun ciondolo. Ottimo lavoro.”
Io risi delle loro sciocchezze mentre passavo in rassegna le opzioni disponibili. Cosa poteva essere adatto a me? Cosa mi rappresentava abbastanza da volere che i miei due migliori amici lo indossassero?
Aaron scelse un orsetto lavatore, che sembrava gli si confacesse. Era difficile da ignorare, rimaneva sveglio fino a tardi ed era piuttosto divertente. Moa scelse un pennello, simbolo del suo amore per l’arte.
Il mio sguardo si posò su un ciondolo che seppi essere perfetto per rappresentarmi. Una nota musicale d’argento, qualcosa di elegante ma semplice e così attinente alle mie passioni da sembrare ovvio.
Avevo cantato per tutta la vita. In effetti mia madre diceva che non avevo imparato a pronunciare frasi con la stessa cura con cui cantavo strofe. Le cuffie sempre appese al collo erano una testimonianza del mio amore per la musica, del fatto che non riuscivo a immaginare di poter passare più di qualche ora senza indossarle e perdermi tra i suoni, in cerca dei momenti della mia vita che mi sottraevano perché non ne avevo il controllo.
La musica mi faceva sentire come se potessi ancora aggrapparmi a qualcosa di solo mio, e cantare era un modo per far sentire la mia voce in un mondo sempre troppo chiassoso, di lasciare un segno quando nessuno voleva ascoltarmi.
“Perfetto.” Aaron portò tutti i ciondoli e le catenine al commesso per pagarli, mentre Moa si lamentava.
Pagavamo sempre io o Aaron, dato che i nostri genitori erano molto più agiati di quelli di Moa. Che cos’erano cento dollari tra amici?
Dopo che lui ci ebbe riportato tutto, fissammo i ciondoli alle catenine e le indossammo. Era una sensazione surreale, come un riconoscimento di quanto le nostre vite stessero per cambiare, con tutti noi in atenei diversi, su percorsi di vita diversi, che ci avrebbero portato in direzioni diverse.
Io e Aaron ci saremmo ritrovati, dato che non avevamo molta scelta, ma mi chiedevo cosa sarebbe successo a Moa. Quella era la fine del nostro piccolo gruppo?
I tre ciondoli erano affiancati, freddi sulla mia pelle calda, e per un attimo desiderai che le cose potessero non cambiare.
Purtroppo avevo la sensazione che niente avrebbe potuto impedire che accadesse.
* * * *
“Devo tornare a casa,” mi lamentai con Aaron tre ore più tardi.
Moa ci aveva già abbandonato, dato che era di gran lunga la più responsabile. Se n’era andata verso le dieci, ma Aaron non era ancora pronto a rientrare e io mi ero fatta corrompere facilmente da un caffè macchiato al caramello.
“Parto domani.” La voce di Aaron aveva perso un po’ di allegria.
“Sarai solo a poche ore di macchina da me,” gli ricordai. “E parleremo al telefono tutti i giorni.”
“Non sarà la stessa cosa. Dai, Hera, non puoi almeno fingere che ti mancherò?”
Mi sfuggì un sospiro, ero stanca di quella domanda. Me la faceva spesso, e mi ci era voluto un po’ per capire perché.
Cosa potevo dire? Semplicemente non pensavo di essere una persona affettuosa, non come lo era lui, non come voleva che fossi. Desiderava qualcuno che lo chiamasse la mattina presto perché non sopportava di non sentire la sua voce. Desiderava qualcuno che non potesse immaginare una vita senza di lui.
E io ci provavo, ci provavo davvero. Impostavo le sveglie sul mio telefono per ricordarmi di mandargli un messaggio o di chiamarlo, e facevo tutto il possibile per recitare il copione che si aspettava da me, anche se non provavo niente di quello che c’era scritto.
“Certo che mi mancherai,” mentii. “Penso solo che tu sia un po’ melodrammatico. Non è che non ci vedremo mai. Potremo farci visita l’un l’altra ogni fine settimana e avremo tutta l’estate da passare insieme. Quello di cui sono certa è che avrai un volo penoso domani, se non dormi un po’.”
Sospirò lentamente, e le rughe sul suo viso, quelle che erano apparse perché non ero all’altezza delle sue aspettative, mi ferirono.
Così lo abbracciai, cercando di essere e fare ciò che desiderava. “Mi dispiace,” gli dissi. “Credo di essere solo un po’ nervosa per il trasloco, per il fatto che sta cambiando tutto, capisci?”
Lui annuì, ma un’ombra nei suoi occhi mi fece capire che probabilmente intuiva a cosa era dovuto il cambio di argomento. “Sì, lo so. Sarà bello, però. Ce ne andremo da questa città, per conto nostro. E chi lo sa? Magari riuscirò ad avere le lezioni nei giorni giusti e potrò dividere il mio tempo tra casa tua e casa mia.”
Sorrisi, anche se rabbrividivo al solo pensiero. Volevo i miei spazi, la mia vita, e non li avrei avuti se Aaron fosse stato la mia ombra tutto il tempo. Ma l’avevo già fatto agitare abbastanza, così annuii. “Sì, sarebbe bello.”
Lui fece un cenno di assenso, come se tutto fosse già deciso. “Perché non...” Uno sbadiglio gli fece lasciare la domanda a metà.
“Ecco... sei esausto e domani ti aspetta una lunga giornata. Dovresti andare a casa e dormire qualche ora prima di partire.”
“Niente sesso di addio?” Sollevò un sopracciglio per fare il paio con un sorrisetto sghembo.
“Ostacolerebbe l’intero saggio proposito di andare a riposare. Le lezioni non iniziano prima di due settimane. E se prendessi un volo per raggiungerti lunedì? Passeremmo una settimana insieme a casa tua prima che io raggiunga casa mia. Così avresti qualche giorno per organizzarti.”
“Per poi battezzare il mio nuovo appartamento?”
“Certo.” Non dovetti fingere un sorriso a quella prospettiva. Il sesso poteva anche non essere strabiliante, ma come per la maggior parte delle cose avevo la sensazione che ‘abbastanza buono’ fosse il massimo in cui si potesse sperare, e l’entusiasmo di Aaron era di notevole aiuto.
Mi offrì un passaggio a casa, ma rifiutai. Se avessi accettato mi avrebbe convinto a ignorare tutte le mie raccomandazioni sul sonno. Inoltre ero arrivata fin lì da sola, e non volevo lasciare la mia auto.
Quando Aaron se ne fu andato potei sorseggiare il mio caffè in silenzio, cosa positiva, dato che non mi era passato il mal di testa.
Nell’ultimo anno avevo sofferto molto di emicrania: per via dello stress, mi aveva detto mio padre. Organizzare il mio primo trasloco, il trasferimento dall’altra parte del Paese... erano cose importanti. Mi stavo preparando a lasciare tutto ciò che conoscevo, le persone, i luoghi, tutto ciò che mi era familiare.
Chiunque ci avrebbe perso il sonno.
Io sentivo che si trattava di qualcosa di più complicato, qualcosa di più profondo, ma visto che non capivo cosa fosse mi accontentavo della spiegazione più semplice.
La folla si era diradata, ora che era passata la mezzanotte. In giro c’era ancora chi faceva baldoria e chi piangeva, ma erano tutti ubriachi, incespicanti e di gran lunga troppo chiassosi. Le loro voci mancavano di armonia, mi davano sui nervi e mi facevano pulsare la testa ancora più dolorosamente.
Mi feci forza e mi spinsi oltre, attraversando la grande area commerciale all’aperto interamente illuminata da lampade a sospensione, diretta al parcheggio. Avevo un posto auto al piano più alto. Mio padre lo affittava ogni anno, così quando veniva a cena non doveva preoccuparsi di dove lasciare l’auto. Dato che veniva raramente, lo usavo io più che volentieri.
Entrai in ascensore, con le mani tremanti e la testa che pulsava. Quando le porte si chiusero serrai gli occhi e inspirai profondamente, cercando di allentare la tensione che avevo dentro e che pensai fosse dovuta ai miei momentanei attacchi di panico. Quegli attacchi continuavano a peggiorare, e anche le pillole che mio padre mi aveva dato non erano servite a molto. Sembravano aiutarmi solo le mie cuffie, che soffocavano il rumore.
L’ascensore si muoveva velocemente e io mi tenevo al corrimano per mantenermi stabile mentre mi si chiudeva lo stomaco.
Rilassati. Respiri profondi, tranquilli e lenti. Ripetei a me stessa quelle istruzioni, come facevo sempre, come mi aveva insegnato il mio analista. L’idea di soffrire d’ansia mi infastidiva. Non avevo nessun motivo di essere ansiosa. Mi faceva sentire come tutti gli altri ragazzi ricchi che non si rendevano conto di avere una vita dannatamente vicina alla perfezione e che quindi inventavano piccoli insensati problemi per poi ingigantirli a dismisura.
Non ero mai stata quel tipo di persona in passato, ma ora sembravo esserlo diventata.
Mi rifiutavo di continuare a sentirmi così, quindi costrinsi il mio corpo a rilassarsi e presi due pasticche di ibuprofene dalla borsa, ingoiandole con il caffè anche se prendere delle compresse con una bevanda calda non era affatto facile.
Quando le porte dell’ascensore si aprirono, avevo quasi recuperato la lucidità. La testa mi doleva ancora, ma il mondo sembrava essere tornato più nitido e non avevo vertigini. Dissi a me stessa che una buona notte di sonno avrebbe fatto al caso mio, che avevo fatto troppo tardi e che avere avuto a che fare con Moa e Aaron era stato eccessivamente impegnativo.
Attraversai il grande parcheggio diretta verso il fondo, dove si trovava la mia auto. Molti posti erano occupati perché quel piano era utilizzato anche dai residenti, che occupavano i condomini proprio al di là del camminamento pedonale. Il che significava che le auto erano tutte costose, dato che non era un posto economico in cui vivere.
Girai l’angolo e mi immobilizzai.
C’erano tre uomini, con felpe scure e cappuccio, di cui uno stava già forzando un finestrino con un grimaldello. Si voltarono tutti verso di me contemporaneamente, e uno di loro curvò le labbra in un sorrisetto che mi riempì nuovamente del panico che avevo provato dentro l’ascensore.
Non era una cosa buona...

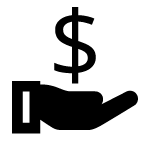
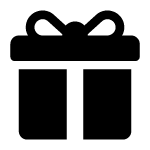
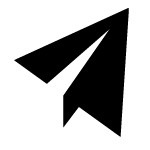
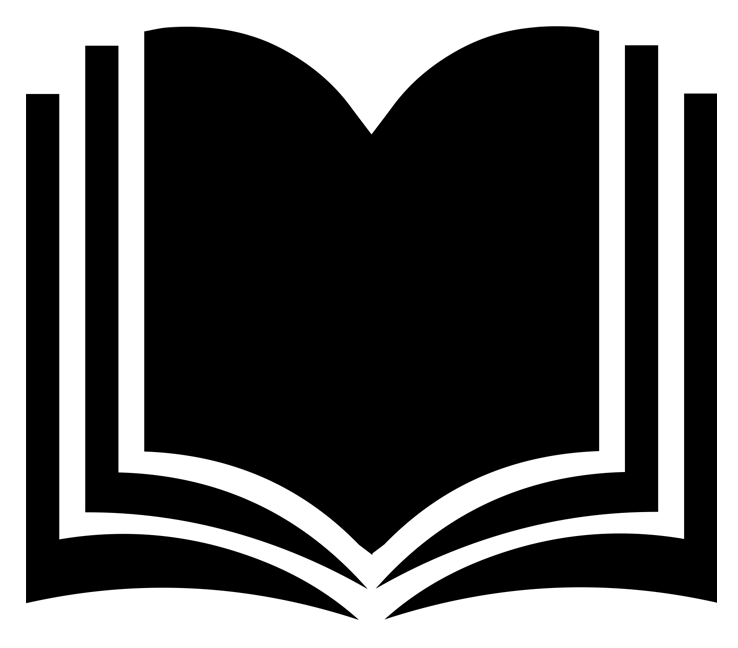














 Facebook
Facebook Twitter
Twitter